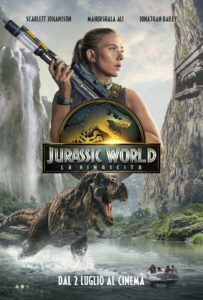Carletto Romeo
“L’invidia dei poveri verso i ricchi” di Gaetano Riggio
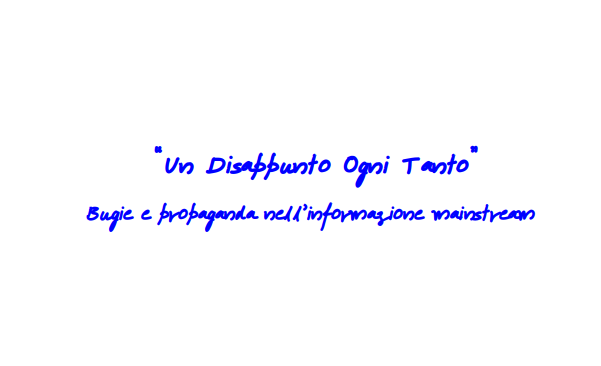
Rubrica di “rilettura” dei giornali mainstream a cura di Gaetano Riggio
“L’INVIDIA DEI POVERI VERSO I RICCHI”
L’ennesima reprimenda contro questo vizio capitale, lo ritroviamo nell’articolo dell’accademico Eugenio Capozzi “Le proteste dei No Bezos … “, apparso sul giornale on line “La Nuova Bussola Quotidiana”, il 30 giugno 2025.
Che fornisce almeno tre ragioni di queste proteste contro il magnate statunitense che ha celebrato le sue sfarzose nozze a Venezia, la prima delle quali sarebbe appunto la “persistenza cronica e l’emergere ciclico, nel nostro paese, di un pauperismo ipocrita mosso in realtà dalla feroce invidia per chiunque primeggi e abbia successo nell’economia, nell’impresa, nelle professioni.”
È il classico “argumentum ad populum”, che fautori, apologeti, e alfieri del neoliberismo, persuasi o prezzolati che siano, amano sfoggiare nello spazio pubblico, perché di immediato impatto persuasivo: che cosa muove intellettuali e masse frustrate a scagliarsi contro i demiurghi dell’economia (in questo caso, Bezos) se non “la feroce invidia per chiunque primeggi”?
Non può non gongolare un simile “maître à penser” al pensiero di avere posto il sigillo (“la ferocia invidia per chiunque primeggi”!) a una questione antica quanto la stratificazione sociale!
Che cosa, e in che modo obiettare alla sicurezza impavida del nostro Eugenio, del quale invito comunque a consultare la bibliografia?
In primo luogo, gli farei notare che l’invidia ha la stessa matrice del servilismo – dal quale non mi pare immune l’illustre studioso – di quanti siedono al banchetto dei “primeggiatori”, e ne raccolgono le briciole sotto forma di prebende, finanziamenti, onorari, e altre poco onorevoli rendite.
Se l’invidioso è agitato da un desiderio che rimane per lo più immaginario (nella forma del risentimento) di abbattere il primeggiatore o di abbassarlo drasticamente al suo livello, il servile si umilia a divenire uno strumento del primeggiatore (vale a dire del padrone): mette intelletto e volontà al servizio dell’uomo di potere (economico o politico) in cambio di protezione e succulente prebende.
Il servile non ignora l’invidia, ma l’ingoia come un boccone amaro, per sfoggiare il sorriso patetico e ipocrita dell’accondiscendenza: impresa titanica, quando il primeggiatore fa sentire tutto il peso anche ricattatorio della sua posizione, e il subordinato non può fare altro che “abbozzare”, se non vuole rinunciare agli onori della servitù!
Sulla condizione dell’uomo servile il nostro Ariosto ha scolpito versi esemplari, che si adattano così bene a descrivere “la corruzione dell’informazione di uno Stato satellite” (Alessandro Orsini) qual è l’Italia, e dunque la corruzione di chi fa informazione e cultura al servizio del padrone, nel nostro paese:
Pazzo chi al suo signor contradir vole,
se ben dicesse c’ha veduto il giorno
pieno di stelle e a mezzanotte il sole.
O ch’egli lodi, o voglia altrui far scorno,
di varie voci subito un concento
s’ode accordar di quanti n’ha dintorno;
e chi non ha per umiltà ardimento
la bocca aprir, con tutto il viso applaude
e par che voglia dir: «anch’io consento».
Sarebbe pazzo il servo che volesse contraddire il suo padrone! Anche se affermasse che il giorno è notte e la notte è giorno, dovrebbe comunque assecondarlo, e dargli man forte quando ordina di lodare o denigrare qualcuno! La libertà del pensiero, è un lusso negato al servile. Quanta attualità in questa caratterizzazione acuta da parte dell’Ariosto!
Insomma, gli autori di panegirici, gli ammiratori e gli emulatori dei primeggiatori, che Eugenio tanto ammira, non sono dunque esenti dall’invidia, ma è gente che, dopo averla ruminata, rigurgita accondiscendenza, ma l’invidia continua a covare dentro di loro come un fuoco che li consuma.
In secondo luogo, il Capozzi pare ignorare che l’invidia è un sentimento naturale, e non sociale e culturale: la riprovazione sociale non la sradica, ma la reprime, perché funziona come la censura freudiana, che colpevolizza l’individuo per obbligarlo a non seguire la pulsione socialmente disapprovata.
In epoca neoliberista, non sono più le pulsioni sessuali a essere censurate, come accadeva ai tempi di Freud – che non a caso scopre l’inconscio studiando l’isteria femminile, legata al rigido e severo ruolo di genere al quale essa era soggetta.
Quella repressione era funzionale al dominio patriarcale sulla donna da parte della società, rappresentata prima dal padre e poi dal marito, e dei genitori sui figli (dei quali vigilavano attentamente sulle inquietudini emotive e sessuali dell’adolescenza.)
La liberazione dell’inconscio femminile è corrisposta alla emancipazione della donna dalla soggezione tradizionale alla dominazione maschile, e dei figli dai padri.
Oggi, è l’invidia, la passione torbida da censurare socialmente, perché disfunzionale alla legittimazione delle colossali disuguaglianze che caratterizzano le società capitalistiche occidentali (e non solo), disuguaglianze che invece devono essere accettate come un dato indiscutibile di natura, per scongiurare qualsiasi forma di contestazione organizzata. Il nostro Eugenio tradisce così il suo ruolo organico di cortigiano di Besoz e compagnia bella.
È evidente così un’altra caratteristica importante: la riprovazione dell’invidia non ha nessuna matrice morale edificante, non si propone affatto di realizzare un individuo superiore, distaccato dalle passioni, nella direzione stoica, oppure cristiana della caritas oppure ancora orientaleggiante di uno svuotamento dell’io per accedere al “sé” riposto. Niente di tutto questo.
Si vuole soltanto un individuo del tutto funzionale al dominio dell’oligarchia al potere, che deve essere soltanto ammirata ed emulata, seguendo il poco probabile miraggio della mobilità sociale, impietosamente smentita dalle statistiche e dalla sociologia (ma il nostro Eugenio lo ignora, anche se non può non saperlo.)
In terzo luogo, come insegna la psicologia evoluzionistica, anche le pulsioni moralmente riprovevoli o degradanti hanno una funzione nell’economia della vita e della società. Noi tutti disapproviamo l’aggressività, per fare un altro esempio, ma un individuo privo di aggressività non avrebbe vita lunga, ma sarebbe votato alla morte. Lo stesso vale per l’invidia.
Non basta riprovare l’invidia, ma capire perché essa possa diventare una passione socialmente dominante: essa è spia e indizio di fenomeni sociali, che stanno a monte, e che la alimentano.
Vorrei infatti chiedere al nostro Eugenio perché un homeless (un senza tetto) di Los Angeles o di un altra metropoli a stelle e strisce dovrebbe prostrarsi in adorazione a seguire le sfarzose nozze di Besoz, oppure perché dovrebbe farlo un suo dipendente, che legittimamente lotta per mezzo di mobilitazioni sindacali per ottenere una quota (salario) meno risicata della ricchezza complessiva prodotta da Amazon, con il suo stesso contributo!
Qui il nostro Eugenietto è imperdonabile, perché esige il masochismo autolesionistico, oppure la deferenza servile neofeudale (che non gli è estranea) al padrone buono. Perché non altro se non masochismo autolesionistico e deferenza servile neofeudale sarebbe una simile prostrazione celebrativa al grande “primeggiatore”.
Dato infatti che pochi tra gli uomini avranno qualche chance di diventare un Besoz, la mera acquiescenza al successo dei pochi condannerebbe un homeless a restare un homeless e un operaio a non potere migliorare la sua condizione lavorativa e salariale. In altri termini, la stessa invidia ha una funzione nell’economia dei rapporti sociali: quando deborda, è indizio di gravi squilibri sociali che richiedono di essere rettificati attraverso una qualche forma di mobilitazione sociale.
Insomma, l’invidia, se diventa fenomeno sociale, è termometro di una febbre che andrebbe curata non con la tachipirina, perché è la conseguenza di gravi squilibri e polarizzazioni, che mettono in grave pericolo la coesione sociale. L’invidia certifica che in una certa società la giustizia è morta o sta morendo.
Gli antichi greci parlavano infatti di “invidia degli dei” (“phtonos ton theon”), che in ultima analisi era la causa che faceva cadere gli uomini affetti da “hybris”, vale a dire tracotanza, sopravvalutazione del proprio ruolo, e dell’eccesso di potere che pretendevano di esercitare sia rispetto agli altri uomini sia rispetto alle potenze divine medesime.
Esisterebbe un limite, sancito da un divieto sacro, che nessun uomo può oltrepassare, se non vuole incorrere nel castigo della sua “hybris”: limite che garantisce l’equilibrio su cui si regge il mondo, e quindi la giustizia.
La giustizia consiste infatti nel dare a ciascuno il suo, secondo una certa misura e una certa proporzione, affinché i rapporti sociali possano svolgersi secondo quell’armonia che permette che le parti possano collaborare per il bene di tutti, di comune accordo.
L’invidia, allora, nella sua negatività etica, è il sintomo che la società è affetta da gravi squilibri, ossia disuguaglianze, che la polarizzano pericolosamente in una minoranza tracotante che esercita un potere economico e politico che travalica e viola la giustizia distributiva e una maggioranza che nell’invidia (che tanto inquieta il nostro Eugenio) manifesta in modo emotivo la sua opposizione a un ordine ingiusto!
Lo spettro del nostro Eugenio, insomma, è la lotta di classe, che non mira necessariamente all’anarchia, ma è movimento politico organizzato delle classi lavoratrici che vivono di salario, per riequilibrare i rapporti economici, e ottenere un ripartizione della ricchezza sociale prodotta più equa, cioè conforme ai criteri della giustizia retributiva.
In quarto luogo, il nostro pare non avvedersi che l’invidia è un inevitabile effetto collaterale della competizione stessa e del culto del successo, che egli pone a fondamento di una società economicamente dinamica e vitale. Anzi non è solo effetto, ma al contempo causa, in quanto la ricerca del successo è mossa essa stessa dall’invidia per chi già il successo l’ha già raggiunto.
Invidia, rivalità, competizione, ricerca del potere e del denaro formano un intreccio indissolubile, dunque. L’invidia – come vorrebbe il Capozzi – non è una prerogativa esclusiva del “pauperismo ipocrita”. Nè è moralmente peggiore dell’avidità, dell’ambizione cinica, e simili.
AL DI LÀ DELL’INVIDIA
L’invidia è comunque categoria psicologica e etica, non politica. Il fatto che il Capozzi la utilizzi politicamente dimostra la sua malafede. Si può infatti lottare politicamente contro lo strapotere dei Besoz anche seguendo un’etica che va al di là dell’invidia, contrariamente a quanto ritiene il Capozzi.
Ho accennato a due vie possibili: quella cristiana della “caritas – agape”, vale a dire dell’amore discendente di chi si mette al servizio degli altri; e quella orientaleggiante dello svuotamento dell’io, per attingere alla propria identità profonda con il Sé universale. Ma questa è tutta un’altra storia.
Per Nietzsche, alla radice dell’invidia c’è la inestirpabile volontà di potenza, che nell’individuo incapace di affermarsi genera il risentimento. Per lui, l’etica cristiana è un’etica del risentimento, in quanto predica un altruismo inevitabilmente falso, che frustra la volontà di autoaffermazione, e tarpa le ali agli individui superiori. L’etica cristiana è l’etica dei deboli, secondo Nietzsche, inetti a lottare, e impegnati a imporre la loro mediocrità agli altri con la minaccia delle pene dell’inferno.
Si possono fare due obiezioni. Primo: anche l’etica dei deboli è un’etica, conforme ai principi che l’unione fa la forza, e che la volontà di potenza va contenuta.
Secondo, la caritas evangelica è un’istanza spirituale superiore, che trascende il livello delle pulsioni biologiche. La caritas non è mero contenimento della volontà di potenza, ma energia spirituale soprannaturale, capace di portare la persona al di là dell’egoismo, verso l’unione con Dio e con il prossimo.
Gaetano Riggio
Segui gli altri “Disappunti Ogni Tanto” di Gaetano Riggio qui:
https://www.carlettoromeo.com/category/un-disappunto-ogni-tanto/
Segui tutti gli articoli di Gaetano Riggio qui:
https://www.carlettoromeo.com/author/shunkawakan8/
carlettoromeo.com è un blog multimediale senza alcuna sovvenzione pubblica…
Se ti piace quello che facciamo, condividi i nostri articoli sui social…
Se vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi farlo con una libera donazione Paypal
GRAZIE